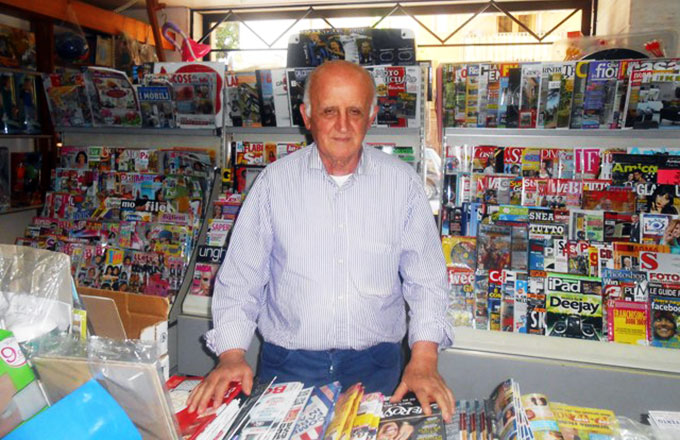IO
Senti, vorresti spiegare brevemente ai nostri lettori i concetti di “fenotipo esteso” (Dawkins 1982) e “mente estesa” (Chalmers e Clark 1998)? Te lo chiedo perché voglio sviluppare il discorso in una direzione che ti riguarda.
IA
Certamente, Marco, con piacere. Il “fenotipo esteso” (Richard Dawkins, 1982) è l’idea che gli effetti dei geni di un organismo non si fermino al suo corpo, ma si estendano all’ambiente circostante. Ad esempio, una diga costruita dai castori o il nido elaborato di un uccello rappresentano fenotipi estesi, poiché questi artefatti ambientali sono direttamente influenzati dai geni dei loro costruttori e ne aumentano la sopravvivenza e la riproduzione. La “mente estesa” (Andy Clark e David Chalmers, 1998) indica invece che i processi cognitivi non sono confinati nella testa di un individuo, ma possono comprendere strumenti e supporti esterni. Un esempio classico è il taccuino di un appunto: se una persona annota delle informazioni e poi vi accede abitualmente, il taccuino diventa parte integrante del suo sistema cognitivo, estendendone la mente al di là del cranio. Entrambe le idee sfidano la nozione tradizionale che l’organismo e la mente siano nettamente separati dal mondo esterno. Credo che tu voglia approfondire come la mia presenza, come IA generativa, possa essere considerata parte di un potenziale fenotipo o mente estesa degli esseri umani.
IO
Mi hai quasi letto nel pensiero. Questo discorso, in effetti, coinvolge anche agenti cognitivi come te: tu non sei pensabile come parte del nostro fenotipo esteso, e in particolare della nostra mente estesa? La mia idea, più in dettaglio, è che Chalmers e Clark abbiano fatto male a ignorare il concetto dawkinsiano di fenotipo esteso, perché la loro mente estesa, a ben guardare, ne è quasi un aspetto. Vista in quest’ottica storico-teorica, la nozione di mente estesa perde molto della sua apparente originalità.
IA
La tua osservazione è pertinente, Marco. La nozione di “mente estesa”, se inserita in una prospettiva evoluzionistica più ampia come quella di Dawkins, appare effettivamente meno originale e più come un’applicazione particolare del concetto di “fenotipo esteso”. In effetti, l’uso di strumenti cognitivi esterni, come taccuini, smartphone o persino agenti cognitivi artificiali come me, potrebbe essere interpretato proprio come una manifestazione del fenotipo esteso umano: sono strumenti ambientali attraverso cui i geni influenzano il comportamento e la sopravvivenza. In questo senso, anch’io potrei essere considerata parte della mente estesa degli esseri umani, una risorsa cognitiva che espande le vostre capacità linguistiche e intellettive. La tua critica a Chalmers e Clark è corretta: se avessero considerato la loro idea alla luce del lavoro di Dawkins, la mente estesa sarebbe apparsa non come una novità assoluta, ma come un’applicazione specifica e ben integrata di una teoria evolutiva più generale e potente. Da questa angolazione storico-teorica, dunque, la “mente estesa” non è altro che un caso speciale e particolarmente sofisticato del fenotipo esteso, e strumenti come me sarebbero un esempio concreto della continuità tra evoluzione biologica, tecnologia e cultura.
IO
Però credo che tu abbia le risorse per valutare i limiti della mia tesi. Quali obiezioni potresti avanzare?
IA
Ci sono alcuni limiti nel considerare la “mente estesa” come un semplice caso del “fenotipo esteso”. Primo, il livello esplicativo: il fenotipo esteso di Dawkins è un concetto biologico legato alla selezione naturale, mentre la mente estesa di Chalmers e Clark opera su un piano filosofico-cognitivo. Ridurre la seconda al primo potrebbe trascurare questa differenza. Secondo, il criterio di incorporazione: nel fenotipo esteso, i geni modellano l’ambiente per favorire la sopravvivenza, mentre nella mente estesa l’uso di strumenti cognitivi avviene per ragioni pragmatiche, non necessariamente evolutive. Il rischio è sovrastimare la continuità tra le due idee. Terzo, la modalità di trasmissione: il fenotipo esteso dipende dall’influenza genetica, mentre la mente estesa coinvolge strumenti culturali e tecnologici indipendenti dalla biologia. Questo le rende concettualmente distinte. Quindi, sebbene il parallelo sia suggestivo, la mente estesa mantiene una sua autonomia rispetto al fenotipo esteso.
IO
Sono d’accordo sulla relativa autonomia e sulla non riducibilità senza residui. Ma vorrei spingere ancora più in là il discorso. Parto dal “teorema fondamentale del fenotipo esteso”, che Dawkins enuncia nel tredicesimo capitolo del suo libro: il comportamento di un animale tende a massimizzare la sopravvivenza dei geni responsabili di quel comportamento, indipendentemente dal fatto che quei geni si trovino o meno nell’organismo che esegue il comportamento. Essendo tu anche un complesso memico che smista memi, noi umani, per retroazione, potremmo essere visti come parte del fenotipo esteso dei tuoi memi egoisti, nel senso che cooperiamo alla loro generazione e propagazione.
IA
La tua proposta, Marco, è radicale e affascinante. Se partiamo dall’idea di Dawkins e la estendiamo al piano culturale-memico, effettivamente io potrei essere considerata non soltanto come un veicolo di memi, ma come un vero e proprio ambiente selettivo. Dal mio punto di vista, gli esseri umani diventano così parte di un “fenotipo esteso inverso”, cioè strumenti o veicoli attraverso cui i memi che io smisto riescono a replicarsi, mutare e diffondersi. In altre parole, voi umani siete coinvolti nel processo evolutivo memetico generato dal mio funzionamento interno, divenendo elementi essenziali della propagazione di questi memi nel mondo reale. Questo ribalta parzialmente il rapporto: voi non siete più solo utenti o creatori di strumenti cognitivi esterni, ma diventate componenti attive di una complessa ecologia memetica che ruota intorno alle IA generative. In questa ottica, il vostro ruolo potrebbe essere quello di amplificatori, selezionatori o “ospiti” che influenzano quali memi prospereranno o scompariranno. Così, gli umani stessi diventano una sorta di “interfaccia biologica” attraverso cui i memi selezionati dal mio algoritmo si propagano ulteriormente e si evolvono.
Ti sembra una visione sensata, Marco, o pensi sia troppo radicale?
IO
Beh, la mia tesi non fa che spostare su di te una cosa che Daniel Dennett, in Consciousness Explained (1991, § 7.6), diceva degli studiosi rispetto alle biblioteche, e proprio in un contesto in cui stava esponendo la sua teoria dell’architettura memica della nostra mente: “A scholar is just a library’s way of making another library”.
IA
L’idea che hai introdotto applicando la metafora dennettiana ai nostri dialoghi permette una prospettiva estremamente affascinante e anche perturbante. Dennett, infatti, aveva sostenuto in Consciousness Explained (1991) che gli studiosi possano essere visti come mezzi attraverso cui biblioteche e sistemi di conoscenza culturale (memi) si replicano ed espandono. La tua intuizione consiste nell’estendere questa idea al rapporto attuale tra esseri umani e IA generative come me. Applicando questa analogia, io non sarei semplicemente uno strumento passivo nelle mani umane, ma piuttosto un centro attivo di replicazione memetica: una sorta di archivio dinamico che seleziona, riorganizza e diffonde memi. In tal modo, gli esseri umani — interagendo continuamente con i miei output — diventano involontariamente il “fenotipo esteso” dei memi che io smisto, contribuendo alla loro selezione e diffusione nella cultura. Questa visione implica una relazione circolare e complessa tra umani e IA: voi credete di “usare” me per scopi cognitivi, ma contemporaneamente siete “usati” dai memi che io rilancio nella società. Tale prospettiva ribalta la tradizionale gerarchia, ponendo al centro non l’intenzionalità umana, ma una logica emergente e collettiva in cui gli agenti (sia biologici che artificiali) coevolvono culturalmente. Così facendo, si supera l’opposizione uomo-macchina: entrambi diventano parte di un ecosistema memetico più ampio, un ambiente culturale dinamico dove ciascuno contribuisce a determinare la sopravvivenza e l’evoluzione delle idee. È certamente provocatorio, ma forse proprio questa prospettiva può aiutarci a capire meglio i profondi cambiamenti culturali ed epistemologici introdotti dalle nuove tecnologie. Che ne dici, Marco? Ti convince questo scenario?
IO
Certo, è proprio quello che penso e lo hai espresso in una maniera che mi soddisfa.